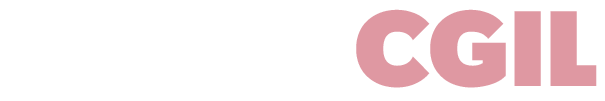L’intervista di Giorgio Sbordoni su Collettiva
Per il segretario generale della federazione Cgil del settore agroalimentare “dobbiamo essere coerenti e dar seguito a quanto stabilito nei congressi. Diritti, salario e lotta alla precarietà”.
“Il cibo è una cartina di tornasole per leggere la società”. Parte da qui la lunga chiacchierata che abbiamo fatto con il segretario generale della Flai Cgil, Giovanni Mininni, per prendere il polso a un settore, quello dell’agricoltura e dell’industria alimentare, il cui tracciato recente racconta molto della situazione che sta vivendo il Paese. Dal diritto al cibo alle battaglie sindacali che si stanno combattendo in questi anni per abbattere la precarietà e allargare i diritti, dal rischio che l’intelligenza artificiale svuoti le fabbriche all’impatto della guerra in Ucraina sul nostro futuro, fa tutto parte dell’analisi di un settore, ancora meglio di un Paese che sta vivendo pericolosamente questo tempo.
Diritto al cibo buono e giusto
“Il diritto al cibo e la cosiddetta sicurezza alimentare sono temi molto attuali nella nostra società a capitalismo avanzato. Per questo, perché il concetto sia esplicitato in modo completo, parlerei di diritto al cibo buono e giusto. Buono, di qualità, perché tutti dovrebbero avere la possibilità di mangiare cibo sano e così non è. Inoltre, Lo spreco andrebbe governato meglio. Ci sono intere fasce sociali che ormai risparmiano sul cibo. Ci sono gli ultimi nei ghetti che comprano la pecora dal contadino per 10 euro e poi la macellano da soli e la mangiano per giorni, senza neanche avere un frigo dove conservarla. E poi ci sono i più ricchi, i privilegiati, che mangiano cibo sempre più raffinato e sempre più spesso soffrono di intolleranze alimentari”. Sono le contraddizioni di una società in cui le diseguaglianze crescono. E anche il cibo diventa un sintomo di queste contraddizioni. “Il paradosso è evidente tra sovrapproduzione dei paesi ricchi e intere aree della terra che restano senza cibo. Ma è evidente anche nella profonda stratificazione sociale all’interno degli stessi paesi ricchi. Tra chi va al supermercato nell’ora di chiusura e compra a metà prezzo prodotti che il giorno dopo non possono essere venduti e chi può permettersi tutto. Lo spreco è ancora più ingiustificabile e inspiegabile visto che intere fasce della popolazione italiana hanno difficoltà materiali di accesso al cibo, dovute a barriere economiche perché il cibo costa e il cibo di qualità costa ancora di più. I consumi alimentari continuano leggermente a diminuire. È chiaro che in un’epoca in cui l’inflazione è più alta dei salari anche la classe media ha fatto sacrifici sull’alimentazione. È stato ancora più evidente durante la fiammata di inflazione forte del 2022”.
“Pensiamo al tema della sovranità alimentare che, di per sé, è un concetto positivo e, detto in parole povere, sarebbe la capacità di un popolo di scegliere quello che vuole mangiare. Nei paesi meno sviluppati questa possibilità non c’è, si mangia quello che si può. In Italia c’è? Solo per alcune classi sociali, le più abbienti. Per le altre di fatto non c’è. Anche qui da noi molte persone si arrangiano, mangiano quello che possono permettersi”.
Gli extraprofitti delle industrie alimentari
La contraddizione esplode anche nelle fabbriche. E qui introduciamo il concetto del cibo giusto, quello per la cui produzione non si sfruttano i lavoratori. “Anche nell’industria alimentare c’è un tema di extraprofitti, proprio come per le banche o i gestori energetici. Gli extraprofitti si sono fatti perché i prezzi dei beni alimentari, per via dei costi in bolletta e dell’inflazione, nell’ultimo anno e mezzo sono saliti e non sono più scesi, persino in questi ultimi mesi, nonostante i costi energetici siano scesi da tempo. Ci sono multinazionali anche italiane che hanno fatto guadagni stratosferici in questo periodo, superiori persino a quelli registrati durante la pandemia. Bisogna trovare un equilibrio che aiuti le classi sociali più deboli. Visto che la crescita del Pil è frutto anche di questi extraprofitti, si dovrebbe trovare una via per redistribuirli”.
Un Paese in cui gli extraprofitti non vengono redistribuiti e la gente risparmia su cibo di qualità e sulla sanità, che futuro ha? “È un Paese che rischia di uscire dal club dei più ricchi anche perché aumentano le disuguaglianze ed è un Paese sempre più esposto a interventi dall’esterno. Basti pensare al famoso Made in Italy e alla fine che fanno gli enormi profitti trainati da questo bollino prestigioso. Restano in Italia? Non sempre. Diverse multinazionali che hanno comprato stabilimenti italiani e intere filiere di produzione italiane spesso non investono tutti i loro guadagni nel nostro Paese, lo fanno in altri paesi e in altre operazioni. Restano in Italia se oltre a pagare le tasse, implementano nuove linee di produzione, creano nuova occupazione, e redistribuiscono i profitti attraverso una fare contrattazione aziendale di buon livello”.
Il cibo giusto
Lo sfruttamento sul lavoro esiste in agricoltura, ma anche nei gangli della produzione industriale. Qualche anno fa ci fu un caso emblematico, quello di ItalPizza. “All’interno di un luogo produttivo è assolutamente necessario che si applichi a tutti coloro che partecipano a quella produzione il giusto contratto. Se fai le pizze non puoi avere il contratto del commercio o della logistica”. Stesso lavoro, stessi diritti, stesso contratto, è un vecchio slogan molto efficace che la Cgil coniò quando iniziò a fare queste battaglie. “Se fai un prodotto alimentare – conferma Giovanni Mininni – devi avere il contratto alimentare. Eppure, ancora oggi, sono le imprese che scelgono il contratto che vogliono applicare”. Come si combatte questa battaglia? “Con la pressione sindacale e con le lotte, con gli scioperi, con una serie di denunce che mettano alle strette i grandi gruppi industriali. Tornando al caso di ItalPizza, infatti, vi erano in quest’impresa contratti diversi da quello alimentare ma poi tutto si è risolto ed oggi siamo in regola. Ma ancora troppo spesso esistono imprese nelle quali, con la propria filiera di appalti e subappalti, costruiscono un gioco di scatole cinesi nelle quali, pur essendo sempre riconducibili alla casa madre, i lavoratori fanno lo stesso lavoro con contratti diversi e differenze di salario che arrivano anche a 300 o 500 euro in meno al mese. Nonostante avessero la stessa mansione. Questo ci dimostra che non devi per forza andare in un Paese meno sviluppato per trovare condizioni di lavoro sfruttato. Anche in Italia si privilegia il profitto rispetto ai diritti dei lavoratori, anche qui esiste concretamente un problema di cibo giusto. Che si parli di consumi o di lavoro, i temi ci sono tutti anche qui, dipende dalla stratificazione sociale”.
Le battaglie sindacali
“La verità è che nella vicenda di ItalPizza siamo riusciti a organizzare i lavoratori, partendo da un manipolo di persone che si è iscritta al sindacato. La Camera del Lavoro di Modena ha coordinato le categorie coinvolte: un’operazione di equilibrio e compatibilità in cui si è scelto di privilegiare i lavoratori. Non è sempre tutto così facile e non è per niente scontato. In altri casi, penso ad alcune battaglie per internalizzare i lavori di pulizia della linea, abbiamo trovato forte opposizione dai lavoratori diretti, perché quello è un lavoro sporco e faticoso e da anni era stato esternalizzato. Queste sono le contraddizioni che ti obbligano al confronto con la realtà. La chiave di lettura non deve essere ideologica, non basta parlare di concetti astratti come la solidarietà o l’unione che fa la forza. L’ideologia ti serve come sistema di valori alla base del nostro agire e per capire dove devi andare, per avere un orizzonte, ma quando fai un’assemblea con i lavoratori devi rispondere ai loro bisogni concreti, facendo i conti con la realtà. L’ideologia serve se la riempi di contenuti e la cali nella realtà e allora ti dà un orizzonte, è una guida, ma se tu la rendi a slogan la banalizzi. La decontestualizzi, la tiri fuori dalla società. L’operaio, come chiunque altro, vuole migliorare la sua condizione. Solo partendo da questo presupposto riesci a capire quali sono le leve per convincerlo. Sono i valori e la motivazione la chiave da usare. Perché dobbiamo unire la classe? Perché se abbiamo la classe frammentata siamo meno forti. E se siamo meno forti è più difficile ottenere quello che vogliamo. Per realizzare le tue aspirazioni di operaio abbiamo bisogno di alleati e l’alleanza possiamo stringerla solo anche con chi sta peggio di te. Chi sta molto meglio non ci aiuterà sicuramente. Così convinco i più garantiti a lottare insieme ai meno garantiti. Per fare questo ci devi parlare con le persone, oggi più di ieri, perché oggi sei rimasto solo tu, non ci sono più partiti che aspirano a una società migliore. Solo tu sindacalista sei sulla linea di frontiera. La contraddizione di una società capitalistica sta nel lavoro. E il lavoro per una questione culturale è stato progressivamente oscurato. Un processo che è iniziato negli anni Settanta e si è rafforzato con il neoliberismo della Thatcher e di Reagan. Il messaggio martellante ha portato alla sostituzione della società con l’individuo. Una sconfitta culturale, visto che il lavoro è per natura un’idea collettiva e i diritti in fabbrica devono esserci per tutti. Noi siamo stati sconfitti culturalmente, però possiamo rialzarci”.
La mobilitazione
Questo è il quadro mentre la Cgil si trova nel bel mezzo di una lunga mobilitazione contro le scelte del governo Meloni. “Le persone si iscrivono ancora perché facciamo buoni contratti e risolviamo problemi. Ma anche tra i nostri serpeggia disillusione, passività, poca partecipazione alle assemblee. È l’altra faccia dell’astensione alle elezioni politiche. La battaglia che stiamo portando avanti sui tre fronti principali – salari, fisco e sanità – la vinciamo se con gli scioperi che necessariamente dovremo fare nei prossimi mesi svuoteremo le fabbriche. Ci vuole questo, più che riempire le piazze. Dobbiamo bloccare le fabbriche. Se ci riusciamo aumenteremo la pressione sul governo. Perché a quel punto anche Confindustria, per continuare a fare gli extraprofitti, spingerà il governo ad accogliere le nostre richieste. In una società capitalistica con le bandiere, gli slogan e le campagne social non facciamo male a nessuno. In una società capitalistica sono i rapporti di forza che cambiano le cose. La proletarizzazione delle classi medie è sempre più veloce e la diseguaglianza tra ricchi e poveri sempre più larga. Le condizioni materiali di molte persone che una volta costituivano la classe media tendente alla borghesia medio alta oggi scivolano verso il basso perché c’è una polarizzazione sempre più spinta dalla mancata redistribuzione della ricchezza prodotta. Questa società, di fatto, è rimasta quella del film di Chaplin, Tempi moderni: le ruote dentate non si fermano, macinano pure gli uomini”.
La piattaforma per il contratto
L’azione sindacale spinge dai due lati. Se l’obiettivo è l’aumento dei salari, da un lato si chiede con la mobilitazione una riforma fiscale che redistribuisca i profitti, dall’altro, in sede di trattativa per il rinnovo del contratto nazionale, si lavora su un aumento. È quello che è stato appena deciso dall’assemblea unitaria di Flai, Fai e Uila, che ha approvato le due piattaforme da portare al tavolo del rinnovo del contratto dell’industria alimentare privata e cooperativa. Sono tre, ci ha spiegato Mininni, le leve su cui hanno agito le categorie dell’agroindustria di Cgil Cisl Uil.
“La richiesta di un aumento di 300 euro per i prossimi quattro anni. L’obiettivo – fatto inedito e non esplicitamente previsto dalle regole del contratto stesso – è il recupero, con una somma salariale, della fiammata inflattiva divampata alla fine del 2021. Una situazione straordinaria. I 300 euro sono la somma della componente Ipca per la difesa dei salari, circa 230 euro, e la crescita degli stessi per 70 euro. Secondo punto, mettere mano alla precarietà, inserendo nella piattaforma una soglia unica del 20% per tutte le somministrazioni, a tempo determinato e a tempo indeterminato. Oggi la legge consente di arrivare fino al 70%. Una scelta, la nostra, dettata non solo dal fatto che i contratti diversi e meno costosi stanno proliferando con appalti e subappalti, ma anche la somministrazione sta rendendo una minoranza i lavoratori cui viene applicato il contratto alimentare all’interno di una industria alimentare. Quindi stop alla somministrazione, 20% massimo, e 5% allo staff leasing. Abbiamo inserito anche interventi che impongano maggiori limitazioni agli appalti. Terzo versante, il tema della riduzione dell’orario di lavoro, al fine di favorire la conciliazione tra tempo di vita, di cura e di lavoro. Quindi riduzione generalizzata da 40 a 36 ore per giornalieri e turnisti”.
I pericoli dell’intelligenza artificiale
Quella di ridurre l’orario di lavoro è anche e soprattutto una risposta alla digitalizzazione sempre più spinta nell’industria alimentare, la premessa che porterà, a breve, all’introduzione dell’intelligenza artificiale. “Il primo salto di qualità nel nostro settore si ebbe con l’avvento del trattore. Un fattore che tolse lavoro. Prima per zappare la terra servivano dieci uomini, poi bastò un trattore. La novità fu accolta positivamente perché rendeva meno faticoso il lavoro, ma l’impatto sull’occupazione fu rilevante. Questo fenomeno si è riprodotto in ogni salto, anche e soprattutto in campo industriale. Dalla meccanizzazione alla digitalizzazione, di volta in volta, si è ristretta la base produttiva. Il tema attuale è che i tempi, da una fase all’altra, prima erano lunghi, oggi sono sempre più corti. Il salto da digitalizzazione a intelligenza artificiale ce l’avremo già nei prossimi mesi, se non nelle prossime settimane. Quattro anni fa questo non era un tema in sede di rinnovo del contratto. I delegati ci hanno raccontato che in molte industrie ormai ci sono i cobot: robot collaborativi non intelligenti che quindi devono essere guidati dall’operatore umano. Le aziende hanno annunciato che da qui a un anno questi cobot diventeranno intelligenti e opereranno da soli. In un caso, in particolare, ci è stato riferito che con il passaggio all’intelligenza artificiale andranno via 15 persone che stanno sulla linea”. Cosa potete fare come sindacato di fronte a una rivoluzione di questa portata? “Non dobbiamo fare i luddisti, distruggere le macchine, prendercela con il progresso. Dobbiamo avere la capacità di capire quello che succederà tra un anno. Devi governare il processo se non ne vuoi essere travolto. La risposta è diminuire l’orario di lavoro e redistribuire il lavoro ad altri lavoratori. E intanto agire anche sulla formazione, perché non tutti sanno lavorare con le nuove tecnologie”. Ma cosa succederà se il fenomeno dovesse diventare ingovernabile? “Le persone che non lavoreranno e che potrebbero venire licenziate nei prossimi anni avranno bisogno di ben altro che il reddito di cittadinanza. Ma c’è un aspetto sul quale dobbiamo riflettere bene. Lo spiego con un esempio. Già sei anni fa visitai un’azienda vinicola in Franciacorta che si avvaleva di robot, in grado di processare i dati dei prodotti. In futuro quel sistema diventerà intelligente e riuscirà a decidere quando fare la vendemmia e farla. In quell’azienda non servirà più né l’operaio né l’agronomo e né l’enologo. Quello che oggi è ancora un professionista stimato e pagato profumatamente. Quindi la nostra fortuna è che pure gli stessi manager da stipendi a 5 zeri tra non molto potrebbero vedersi rimpiazzati da un’intelligenza artificiale. L’unità di classe ce la potrebbe imporre questo ulteriore sviluppo”.
Il cambiamento
Di fronte a un mondo che raggiunge questo grado di complessità, quale approccio dovrebbe avere il sindacato? “Il sindacato deve arrabbiarsi e lottare più di prima. Oggi in questi processi non ci siamo. Ma se non riusciremo a governarli sarà la fine per il sindacato. La società capitalistica è una società che corre e tu devi correre altrettanto, altrimenti non tieni il passo. E noi, a volte, fatichiamo a tenerlo. In Flai per queste ragioni abbiamo riattivato la scuola di formazione politico sindacale. I nostri delegati sono bravi e coraggiosi ma a volte – complice la sconfitta culturale della nostra parte – li senti ragionare della ‘mia azienda’ o citare la formazione che hanno ricevuto dall’azienda stessa. La formazione non è mai neutra. In molti casi è evidente che si sentano più parte dell’azienda che del sindacato. C’è il rischio di una deriva neocorporativa. Manca l’identità di classe, dobbiamo ricostruirla. Dobbiamo insegnare a un delegato a leggere il contratto, a leggere la busta paga, dobbiamo dargli la fatidica cassetta degli attrezzi? Anche, senz’altro. Ma possiamo limitarci a questo? No. Noi abbiamo una serie di valori che non possiamo più permetterci il lusso di oscurare ai lavoratori. Noi nelle assemblee non dobbiamo spiegare solo come è composto il contratto, dobbiamo raccontargli la piattaforma dal punto di vista complessivo, più ampio e spiegare perché abbiamo scelto di proporre quei temi in piattaforma, perché quella filosofia risponde ai bisogni materiali delle persone. Dobbiamo migliorare la nostra capacità di lettura della fase e ci dobbiamo rimboccare le maniche, fare le cose che vanno fatte. Per questo è ripartita la scuola sindacale”.
La guerra
Su tutto quello che ci siamo detti finora agisce però una variabile impazzita e dagli esiti imprevedibili. La guerra che si combatte in Ucraina, ma che sta infiammando il mondo intero. Quali sono i pericoli e le derive? “Intanto, io credo, il clima di assuefazione. Nei media è ormai una delle tante notizie e le persone la percepiscono così. Nell’assuefazione il pericolo è quello che si radicalizzi lo scontro. Adesso si ragiona di F16, carrarmati ipertecnologici, a un anno di distanza. A febbraio prossimo di cosa parleremo? La cosa sconcertante è l’idea di usare il Pnrr, uno strumento creato per favorire la ripresa economica dell’Europa, per produrre armi. Questo fa di noi europe ancor di più dei cobelligeranti e la propaganda di guerra diventa sempre più asfissiante. Una follia che segue quella del sostegno a una decisione degli americani, nata e coltivata in un quadro geopolitico ben più ampio in cui quando verrà al pettine il nodo della rivalità con la Cina, la Russia sarà sfiancata da anni di conflitto. Decidere di destinare i soldi del Pnrr alle armi è un ulteriore suicidio per l’Europa. Il Recovery Fund è nato per dare una scossa all’economia europea dopo la crisi dovuta alla pandemia e per renderla più competitiva rispetto alle altre economie del mondo, anche verso quella statunitense, a volte nostra concorrente sui mercati globali. L’Europa resta il mercato più ricco al mondo, è un boccone prelibato e proprio per questo è ambito sempre di più. Destinare risorse del Pnrr previste per il rilancio delle nostre economie e per migliorare la qualità della vita delle persone all’acquisto di armi per una guerra che non è “la nostra guerra” è un errore madornale che si somma a quello già compiuto quando l’Europa non è riuscita ad impedire lo scoppio del conflitto. L’Europa sarà ancora più indebolita sul piano economico e sociale se i vari governi decideranno di usare quei soldi per le armi. Ma chi la governa è talmente succube e debole politicamente che non vuole capirlo non ha il coraggio di cambiare rotta. La guerra sta peggiorando le condizioni di vita dei cittadini europei, ma nessuno fa niente per fermarla. Ci prova solo il Papa”.